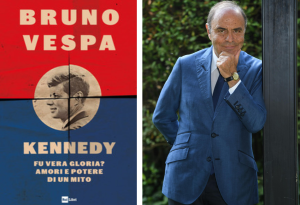Grazia Lops: «Parto di cuore per cancellare i pregiudizi sulle adozioni»

LIBRI Grazia Lops ha 51 anni. È nata e vive ad Andria, in Puglia, con suo marito con il quale è sposata da 18 anni. È una commercialista e consulente del lavoro che suona il pianoforte, adora Mozart e passa molto tempo a leggere e a scrivere. Dalla sua penna – e soprattutto dalla sua vita – è nato Parto di cuore – Dall’Etiopia alle Filippine: il miracolo dell’adozione internazionale, uscito lo scorso 26 giugno (edito da Tau).
Il suo primo libro, 150 pagine di vita vissuta, racconta la sua esperienza con Isabel Tsegereda, 11 anni il 9 agosto, e Jacob, che di anni ne compirà 9 il 20 ottobre. La prima viene dall’Etiopia («La costruzione del nome ha un senso – spiega subito l’autrice -, la nonna si chiama Isabella e se avessi avuto una “figlia fatta in casa” l’avrei chiamata così; Tsegereda significa “rosa” in etiope ed è un nome molto bello, è il suo nome»), il secondo dalle Filippine. Sono i suoi figli. E guai a parlarne come di “figli adottivi”. Spiega tutto nel libro che oltre ad un’esperienza personale è un j’accuse contro stereotipi, tabù e pregiudizi sull’adozione.
Signora Lops, iniziamo dal titolo: “Parto di cuore”…
«È un libro nato da un percorso particolare: lo considero quasi il mio terzo figlio, quello che mi ha condotto ai miei due cuoricini, Isabel Tsegereda e Jacob. È un viaggio pieno di emozioni che nasce come un diario indirizzato ai miei figli e alla mia famiglia: Tsege sta con me da 10 anni e Jacob da oltre 5. Ho iniziato a scriverlo oltre 10 anni fa come promemoria. Era pronto già 4 anni fa, ma non ho trovato una casa editrice che lo pubblicasse. Mi è piaciuto mettere nel titolo la parola “parto” nel suo doppio significato di “partire” e “partorire” per esprimere il mio desiderio di essere mamma. Io sono partita da e con il mio cuore per partorire il mio più grande desiderio, quello di diventare madre».
Come è avvenuto il passaggio dal diario al libro?
«Non è stata solo un’esigenza personale; mi ci hanno spinto alcune persone che mi chiedevano informazioni. Facendolo diventare un libro l’ho usato come mezzo per spiegare, prima di tutto, che l’adozione non è un ripiego. Ci ho messo molto prima di pubblicarlo. Avevo diversi timori: non è facile scrivere tutto quello che ho vissuto in un libro senza sapere a chi arriverà e chi lo leggerà. I bellissimi riscontri che mi stanno arrivando mi rassicurano; però, devo ammettere che l’idea che qualcuno, proprio adesso, mentre stiamo parlando, possa star leggendo il mio libro mi intimorisce ancora».
Nel libro lei parla di “PSL” che l’hanno indotta alla pubblicazione. Chi sono?
«Coloro che mi hanno dato la spinta decisiva verso la pubblicazione. I “PSL” sono i professori senza laurea che incontriamo nella vita: sono quelli che non sanno nulla, ma dettano legge dando pareri quasi giuridici: “questa cosa va fatta così”, sentenziano. Ho scritto quello che penso sulla famiglia, sulle adozioni e sui legami di sangue così non devo più ripetere le stesse cose ai tanti che incontro ogni giorno».
Signora Lops, se la sente di raccontarci come è arrivata a pensare all’adozione?
«Mi ha sempre affascinato il mondo dell’adozione, soprattutto il rapporto che si crea tra genitori e figli adottivi. Io credo che siamo tutti figli del mondo e che i legami di sangue siano relativi: la famiglia è crescere insieme. A volte si vive insieme perché biologicamente capita così, a volte ci si ritrova a convivere in un mix. Quando ci siamo sposati, mio marito ed io, non riuscivamo ad avere figli. All’inizio è stato doloroso, ma poi ho proposto a mio marito l’adozione, “da dove vengono, vengono”, gli ripetevo. Così è stato. Bisogna spazzare via gli stereotipi sui legami di sangue. L’adozione è stata sempre ritenuta un ripiego. Credo invece che sia la strada giusta per chi ha posto in casa e nel cuore. Ci sono tante famiglie che convivono con figli biologici e figli adottivi, senza distinzioni di sangue. Noi quattro non siamo legati da vincoli di sangue, ma siamo comunque un tutt’uno: guai a chi ci tocca».
Come ha capito che proprio Tsegereda e Jacob sarebbero stati i suoi figli?
«Adesso posso dire che è stato facilissimo partorire col cuore. La gestazione adottiva è fatta di percorsi di attesa che ti portano a quello che sarà poi tuo figlio. Loro erano i miei figli, l’ha sentito il cuore. Quando qualcuno mi diceva: “che bello, hai adottato due bimbi”, mi innervosivo; io non ho adottato due bambini, io ho adottato due figli. L’ho fatto quando ho capito dove la mia cicogna li aveva portati».
A proposito di cicogna: l’immagine di copertina del suo libro è una mongolfiera e nel libro lei fa riferimento a una cicogna. Ci spiegherebbe queste scelte?
«Quando si viaggia con un qualsiasi mezzo di trasporto, treno, macchina o aereo, ci sono tragitti precostituiti e orari da rispettare. La mongolfiera, invece, è il mezzo della fantasia: per poter decollare bisogna lasciare a terra le zavorre che, in questo caso, corrispondono ai pregiudizi e agli stereotipi. Ho dovuto chiedere aiuto alla mia cicogna – che è il mio alter ego, la mia coscienza nel libro – per seguire il percorso che mi ha portata a diventare mamma. Con la mongolfiera e la cicogna ho fatto due viaggi: la prima volta in Etiopia, a Addis Abeba, e la seconda nelle Filippine, a Manila. Nel libro ho inserito anche un piccolo vademecum per chi volesse seguire questo percorso».
Quando Isabel Tsegereda era già con voi da tempo è arrivato Jacob. Immagino che abbia dovuto lavorare sulla creazione della friatria tra i suoi figli…
«È stata dura. Prima di tutto abbiamo dovuto preparare mia figlia all’accoglienza: Tsegereda è arrivata da noi quando aveva pochi mesi mentre Jacob e venuto quando aveva già 4 anni, era un bambino grande. Mia figlia mi chiedeva spesso: “mamma, perché gli altri hanno fratellini microscopici e il mio è grande?”; altrettanto spesso voleva che lo mandassi via perché invadeva i suoi spazi. Adesso sono in tutto e per tutto sorella e fratello: si amano e litigano che è un piacere vederli».
Diceva che Tsegereda era piccola quando è arrivata da voi, ma Jacob era più grande: ci sono state “aspetti” del suo contesto culturale che il bambino si è portato dietro dalle Filippine?
«Certo. Quando è arrivato, parlava due lingue: inglese e tagalog, una lingua locale. Abbiamo dovuto risolvere, prima di tutto, un problema comunicativo. Poi Jacob, come sempre avviene in questi casi, ha messo da parte entrambe e ora parla italiano. In verità, pronuncia anche qualche parola in dialetto… Chiaramente il loro inserimento in generale non è stato facilissimo. Qualche volta mia figlia mi chiedeva: “mamma, ma io sono italiana?”. Le rispondevo: “certo, sei italiana con origini etiopi come Jacob è italiano con origini filippine. Anche mamma e papà sono italiani, ma grazie a voi si sono mixati così siamo tutti più completi e colorati”.
C’è stato un momento in cui ha pensato di non farcela con l’una o con l’altro?
«Ovviamente. La difficoltà maggiore l’ho incontrata con il secondo. Quando eravamo in tre eravamo riusciti a raggiungere un equilibrio familiare. L’arrivo di Jacob ha rimesso tutto in gioco ed è stato necessario creare un equilibrio completamente nuovo. Ci dissero che parlava lingue diverse, che si arrampicava sui mobili… Cose che fanno tutti i bambini, almeno quelli sani: provi a portare un bambino in un bosco e vedrà se non cercherà di arrampicarsi su un albero… Oggi i bambini si stanno facendo diventare dei perfetti deficienti, sempre con un tablet in mano, fermi senza nemmeno camminare più. Quando Jacob è arrivato ho pensato di averla fatta grossa: temevo di non riuscire a far diventare fratelli due bambini che venivano da contesti così diversi. Alla fine, però, ce l’ho fatta».
Arriverà il terzo?
«Il terzo è già arrivato con questo libro. Forse il quarto, chissà…».
PATRIZIA PERTUSO
© RIPRODUZIONE RISERVATA