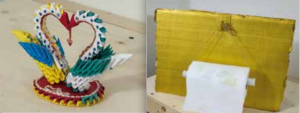Prandi: «Il dolore di chi sopravvive al femminicidio non passa mai»

Dietro ogni crimine commesso non c’è solo la vittima “diretta” che lo ha subìto. Ce ne sono molte altre, tutte quelle che “restano” e che subiscono conseguenze indirette: sono le vittime secondarie, che, in realtà, tutto sono meno che “secondarie”. Stefania Prandi, giornalista professionista, scrittrice e fotografa freelance, collabora con testate internazionali e ha vinto numerosi premi. Si occupa di diritti umani, sfruttamento sul lavoro, violenza di genere, questioni sociali, ambiente e cultura. Insegna al Laboratorio di giornalismo femminista dell’Università di Venezia. Con la mostra “Le conseguenze. I femminicidi e lo sguardo di chi resta”, dal 16 (inaugurazione alle 18) al 25 maggio, alla Biblioteca Sormani di Milano, promossa e organizzata in collaborazione con Libere Sinergie (associazione impegnata nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione contro le donne), GiULia (associazione nazionale di giornaliste impegnate a combattere il gender gap nelle redazioni e a modificare lo squilibrio informativo sulle donne sui media anche utilizzando un linguaggio privo di stereotipi) e il comune, dà voce a queste “vittime secondarie”.
Signora Prandi, nella mostra sono esposte 30 foto e quattro lettere: ci racconta il percorso espositivo?
«All’ingresso, ci sono due pannelli introduttivi scritti uno da me e uno da Chiara Cretella (la curatrice del catalogo, ndr). Poi sono esposte 30 foto di 5 famiglie, anzi, di 5 madri le cui storie sono tratte da un libro che ho pubblicato con la casa editrice Settenove e che si intitola “Le conseguenze. I femminicidi e lo sguardo di chi resta” pubblicato nel 2020. La differenza tra il libro e la mostra è che mentre nel testo ci sono anche delle delle testimonianze di uomini, nonni e un figlio per esempio, nella mostra ci sono solo quelle di donne tranne la foto di un padre e non per mia scelta. I maschi, padri, figli o fratelli non hanno voluto sostenere la parte fotografica».
Come mai non l’hanno avuta sostenere secondo lei?
«Farsi fotografare rispetto a un tema così delicato vuol dire sicuramente mettersi molto in gioco, significa fidarsi della persona che si ha di fronte perché il rischio è che si cada nella banalizzazione e nella pornografia del dolore. Credo che le donne siano state più coraggiose. I parenti delle vittime di femminicidio fanno diventare il loro dolore politico attraverso attività sociali affinché quello che è accaduto loro non sia successo invano. Vanno nelle scuole a raccontare le loro storie, organizzano manifestazioni, frequentano i centri antiviolenza, aiutano i cosiddetti orfani speciali, si aiutano tra loro. Questa mostra è un’attestazione del fatto che le loro figlie non vengano dimenticate e non siano considerate come un numero tra quelli che appaiono negli elenchi delle vittime di femminicidio».
In base a quello che mi dice, il comportamento di Gino Cecchettin sembrerebbe “anomalo”…
«Per come funziona il sistema dell’informazione il caso Cecchettin rischia di apparire un po’ ingiusto perché viene ricordata soltanto una vittima, Giulia. Ma non è ovviamente colpa della famiglia: è colpa del sistema mediatico che ne ricorda solo una e dimentica tutte le altre. È stato un caso così mediatizzato probabilmente per le sue caratteristiche: la prossimità con il 25 novembre, la denuncia di sparizione con il conseguente tentativo piuttosto morboso da parte dei social media di cercare la ragazza, il fatto che c’era già chi la pensava morta – e questa è una cosa grottesca -, il fatto che fosse la “vittima perfetta” (una ragazza acqua e sapone, irreprensibile nei suoi comportamenti). Poi, c’è stata la sorella di Giulia che ha avuto una grande consapevolezza femminista: ha parlato con forza, è stata attaccata da alcuni politici e ha avuto il coraggio di rispondere loro. Credo che da qui si sia creato il caso. Ritengo che sia molto meritevole da parte loro quello che stanno facendo. Mi chiedo solo quanto sia difficile per la sorella che è molto giovane reggere una situazione di questo tipo. Quando si torna a parlare del crimine che hanno subìto e delle ingiustizie vissute durante i processi, le madri che ho incontrato vivono una condizione di ri-traumatizzazione».
Immagino che la condizione di vittima “indiretta” che investe chi resta sia quella più difficile da smantellare, da digerire, impossibile da dimenticare.
«Esattamente. C’è quella che viene chiamata vittimizzazione secondaria, la colpevolizzazione secondaria. Una delle madri con cui ho parlato, Giovanna Ferrari, mamma di Giulia Galeotto, durante un incontro al Festival dei diritti umani a Milano raccontava che spesso veniva vista con sospetto anche dalle stesse psicologhe che le ponevano domande come se lei fosse stata una madre inadeguata, come se avesse cresciuto una donna incapace di essere abbastanza emancipata. C’è sempre questo sospetto che aleggia su di loro, questa critica. La vittimizzazione generalizzata viene applicata a tutti i crimini di genere contro le donne e viene riservata anche ai familiari».
Torniamo alla mostra, Prandi. Accanto alle 30 fotografie ci sono quattro lettere di altrettante mamme scritte alle figlie che non ci sono più. Ha scelto di inserirle per dare una continuità narrativa all’impianto visuale?
«Nasco come giornalista e poi, in un secondo tempo, fotografa. Di solito lavoro con immagini che cercano di scardinare un certo tipo di narrazione iconografica accompagnate da testi. Nelle mie foto non ci sono donne con gli occhi pesti, né persone che piangono. L’idea è quella di restituire, attraverso le immagini, un’intimità del dolore o di quello che si può vivere come conseguenza della violenza di genere mantenendo sempre la dignità assoluta delle persone. Penso sempre a come mi sentirei se fossi io a essere fotografata. Si tratta di immagini dalle quali si intuisce che qualcosa non va, ma si comprende l’evento luttuoso solo leggendo le didascalie. Per questo è importante che i testi siano forti. Devo dire che ogni volta che li sento rileggere resto sempre sorpresa dalla capacità che hanno avuto le madri di non essere assolutamente retoriche pur scrivendo testi molto potenti».
A proposito di potenza: nelle sue foto vengono ritratti spesso degli oggetti-simbolo, dalla catenina fra le mani di una mamma al vestito che porta ancora «l’odore della figlia» uccisa. Pur non presentano alcun segno di violenza, sono foto “potenti” nel mostrare un dolore dignitoso: alcune sono agghiaccianti più di quanto possa essere agghiacciante la vista di un cadavere a cui ormai siamo quasi abituati, purtroppo. Come è riuscita a cogliere e a fermare in uno scatto questo dolore espresso attraverso oggetti simbolici?
«Sono delle scene che si sono create spontaneamente. Questo tipo di progetto si è sviluppato in collaborazione con le persone che ho fotografato. C’è stato con loro un dialogo costante. Quando le ho incontrate ho dichiarato subito quali fossero i miei intenti e ho cercato di distanziarmi dal tipo di narrazione dominante che c’è ancora, purtroppo, dicendo loro che non volevo assolutamente scivolare nel pietismo. Con alcune famiglie si è sviluppato un rapporto più stretto, alcune madri hanno deciso di mettersi più in discussione di altre, e la mamma Giovanna Ferrari mi ha mostrato volontariamente la catenina di sua figlia. Ha scelto di mostrarmi anche l’abito da sposa che le aveva cucito lei. Io le avevo chiesto se mi poteva mostrare degli oggetti di Giulia e lei aveva scelto qualcosa che faceva parte della vita quotidiana della figlia e che aveva tenuto: i vestiti, perché alcuni li indossa lei ora, avendo la stessa taglia di Giulia».
Signora Prandi, come è riuscita a creare un’empatia così forte? In fondo, lei per queste donne era una sconosciuta…
«Penso che abbiano apprezzato la mia chiarezza su un obiettivo trasparente: ho detto loro che avrei fatto le foto e poi gliele avrei mostrate; nel caso non fossero andate bene, le avrei cancellate. La stessa cosa l’ho fatta per i testi. Non hanno cambiato né inserito nulla se non qualche correzione su alcune date. Avere la sicurezza e la padronanza sul materiale che viene prodotto credo che sia importante come è importante il fatto che in questo progetto non c’è stato un contraddittorio. Tutte le famiglie sapevano che io non sarei andata a casa dell’aggressore come invece accade in alcune trasmissioni dove si presentano entrambi i punti di vista come se fossero simili mentre in realtà sono opposti. Non per essere manichei, ma è chiaro che quando una donna viene uccisa c’è qualcuno che ha torto e qualcuno che ha ragione nel senso che deve essere difeso dalla società e deve ottenere giustizia. Questo processo purtroppo è stato sfilacciato da alcune trasmissioni televisive».
Secondo la sua esperienza queste madri sentivano la necessità di raccontare il loro dolore e di fissarlo in una fotografia perché superasse il tempo e lo spazio diventando quasi un’astrazione?
«Francamente non lo so. Credo che da parte loro l’aspetto veramente importante sia stato quello di far ricordare le figlie, di fare in modo che la morte non fosse avvenuta per niente, di far capire che non è stata una loro sfortuna, che non è che è stata colpa della figlia, che non era una poco di buono, perché questo è quello che viene fuori spesso durante i processi. Gli avvocati difensori fanno di tutto per ottenere una riduzione della pena per le persone che rappresentano e invocano l’incapacità di intendere e di volere, indagano in maniera ossessiva nel passato delle vittime scavando fin nei più piccoli dettagli, cercando di farle apparire come poco di buono. Per le madri tutto questo è molto doloroso. Credo che lavori giornalistici come questo possano essere un modo per avere un’altra forma di giustizia oltre quella dei tribunali nella quale, a volte, i familiari non ottengono abbastanza. Credo che possano fissare il ricordo delle figlie morte e cercare di fare in modo che la loro scomparsa non sia stata inutile. Poi – però questo non me lo hanno mai detto direttamente, è una mia impressione -, è anche un modo per cercare di andare avanti. Questi sono dolori che non solo non passano, ma diventano ogni giorno più difficili da reggere».
PATRIZIA PERTUSO
© RIPRODUZIONE RISERVATA