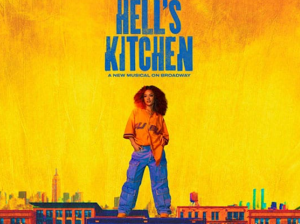«Il carcere infantilizza, il teatro in carcere restituisce umanità»

Christian ha 48 anni, 26 dei quali passati in diverse carceri italiane. Ora usufruisce dell’articolo 21 della Legge sull’ordinamento penitenziario che prevede la possibilità di lavorare all’esterno durante il giorno, seguendo regole ben precise, e di tornare la sera nell’istituto di reclusione dove si sconta la pena. Ha cominciato a fare teatro in carcere nel 2010, a Bollate, con la compagnia Estia fondata e diretta da Michelina Capato.
«Ho iniziato a fare teatro fin da bambino – racconta -. Alle elementari avevo una maestra che è stata la mia prima Michelina, un’amante del teatro, ci faceva mettere in scena degli spettacoli. A 14 anni, dopo le medie, ho preso la mia strada e quella è diventata la mia storia. Tornare a fare teatro con Michelina in carcere mi ha dato la possibilità di riprendere quel sogno nel cassetto e di farlo diventare reale».
«Sono rimasto in quella compagnia – prosegue Christian – fino a gennaio 2018 quando purtroppo Miki, per sue vicissitudini personali, è andata via. Il suo impegno andava oltre il teatro: cercava di offrirci la possibilità di un lavoro perché per persone come noi, che spesso arrivano da contesti un po’ periferici e hanno conosciuto il “guadagno facile”, è difficile tornare alla vita “esterna” restando nelle regole. Si fa molta fatica mentalmente. Quello che manca principalmente sono le relazioni: uno ci può mettere tutta la volontà che vuole, può aver capito i propri sbagli, ma poi una volta che entra in difficoltà o va sotto pressione è come se si trovasse di fronte a una porta che ha già sfondato. L’ha chiusa, ma la chiave la conosce. Onde evitare di riprendere quella strada si ha bisogno di un sostentamento nelle relazioni perché senza si torna nel proprio circuito».
Lei ora è nel carcere di Bollate, definito un “carcere modello” per il bassissimo tasso di recidiva.
«La media nazionale è intorno al 70%, a Bollate scende al 18%».
Secondo lei come mai?
«Io, oltre a Bollate, ho avuto “la fortuna” di girare la catena alberghiera delle carceri italiane, ho avuto il “piacere” di visitare una ventina di istituti e quasi potrei scrivere una guida Michelin. Le posso dire che i punti di forza di Bollate sono stati il Provveditore, la Direttrice, il Comandante e il Responsabile della rieducativa oltre alla stessa Michelina per l’area artistica. Queste persone illuminate hanno compreso la potenzialità della distensione puntando sul lavoro, sulla cultura, sull’istruzione. Se si guarda l’ordinamento penitenziario sembrerebbe di aver scoperto l’acqua calda, ma, in realtà, dalla teoria alla pratica il passo è molto lungo».
Cosa intende precisamente con distensione?
«La distensione è quella che istituzionalmente si chiama “responsabilizzazione del detenuto”. Io che parlo come mangio la vedo come un coinvolgimento attivo del recluso. Bollate viene definito un “carcere modello”. Scherzosamente aggiungerei che il modello adesso ha vent’anni e forse dovrebbe essere già stato esteso, ma non è così. Quella del coinvolgimento attivo del detenuto è stata la vera rivoluzione del sistema carcerario di Bollate con una sorveglianza cosiddetta dinamica, che consente cioè al detenuto di condividere gli spazi e di avere un contatto con il mondo esterno grazie alle attività laboratoriali e ai volontari perché ogni istituto è chiuso in sé. Si fa fatica ad avere rapporti con il territorio circostante che dovrebbe essere partecipe nell’opera di rieducazione, reinserimento, avvicinamento e accettazione. Nella maggior parte degli istituti purtroppo non è così tant’è vero che quelli nuovi ora li spostano in periferia per non avere fisicamente la loro presenza all’interno della città. Bollate ha una grande forza nella città di Milano che ha accolto la struttura carceraria nell’area metropolitana e ha dato anche all’esterno la possibilità di offrire questa risorsa. Perché il carcere può essere una opportunità e una risorsa come può essere una discarica. Dipende da come si usa».
I termini “rieducazione” e “responsabilizzazione” sono molto forti: fanno pensare ai reclusi come bambini piccolissimi e irresponsabili…
«Nel sistema penitenziario esiste una cultura di infantilizzazione: c’è la domandina da compilare per qualsiasi cosa, c’è lo scopino che è l’addetto alle pulizie, c’è il cellino che è la cella singola peraltro molto ambita. L’atteggiamento infantilizzante si esplica anche nell’uso di questi termini».
Si tratta di infantilizzazione o sottomissione? Il detenuto-bambino è piccolo, inferiore rispetto a chi ha di fronte…
«Qualcuno cerca di renderti piccolo. È un po’ come sottolineare sempre: “visto che fuori facevi il grande, adesso ti faccio diventare piccolo”. Credo che pensare di avere a che fare con presunti bambini faccia fare meno fatica piuttosto che pensare di avere a che fare con degli uomini».
Lei, da detenuto, si è sentito infantilizzato o sottomesso?
«Personalmente non mi sono mai sentito infantilizzato forse perché ho sempre fatto il bambino ribelle e quindi si finiva sempre con un testa a testa. Però è proprio grazie a quegli strumenti di cui parlavo prima – la conoscenza, l’apertura della mente, il sapere, il teatro – che si può capire tutto questo. La mia prima carcerazione risale al 1994, ho trascorso 26 anni di carcere in diverse strutture. La mia vita l’ho passata dentro e ho i mezzi per fare una buona analisi che mi porti a comprendere determinate cose. L’infantilizzazione non riguarda solo il detenuto, ma anche il corpo di polizia penitenziario: anche gli agenti entrano nel merito di un’osservazione».
Anche alcuni di loro sono anche “reclusi” vivendo all’interno del carcere.
«Assolutamente sì. Anche gli agenti penitenziari fanno la loro galera. La distensione in un istituto giova a tutti e, soprattutto, dà concretezza e strumenti alle persone che non ne avevano fuori perché possano conoscere se stessi, imparare dei mestieri, relazionarsi».
Torniamo al teatro. Dopo il ritiro di Michelina Capato lei ha fatto di tutto perché l’attività teatrale proseguisse…
«Michelina si è ritirata nel 2018. Noi dovevamo andare al Piccolo Teatro con uno spettacolo che avevamo scritto durante l’estate perché le attività laboratoriali finivano a giugno. Siamo ripartiti da quello. Eravamo gli orfani di Michelina: lei non c’era più, ma avevamo preso questo impegno. Ed era come se con questo spettacolo, “Ci avete rotto il caos”, potessimo mostrare quello che ci aveva dato. Abbiamo fatto tutto noi: luci, regia, drammaturgia. Non potevamo disperdere l’eredità di Miki. Dovevamo mantenere vivo tutto e non potevamo buttare via ciò che avevamo creato in quel piccolo spazio di libertà. Quel teatro per noi era diventato un simbolo».
Così, gli orfani di Michelina sono diventati I figli di Estia.
«Esattamente. Estia è la dea del focolare. Noi siamo I Figli di Estia, la compagnia teatrale che fa parte dell’associazione PrisonArt».
Il teatro si basa sull’uso del corpo: ascoltate alcune musiche e poi improvvisate movimenti che vengono montati poi in piccole coreografie.
«Facevamo e facciamo teatro danza e il linguaggio del corpo ne era la base. La prima cosa che si presenta ad uno spettatore è il corpo. E la musica, che di per sé ti muove emotivamente, è un tappeto importante».
In una situazione di costrizione come quella della reclusione quanto è importante poter muovere liberamente il corpo sulle note di una musica?
«La nostra particolarità è quella di essere persone ristrette. Il teatro ti muove e ti smuove, ti permette di esprimerti liberamente attraverso il corpo. Essendo tutto ristretto assume una connotazione ancora più potente. Per questo abbiamo quasi occupato lo spazio del teatro perché restasse nostro. È uno spazio di libertà senza condizionamenti. Quando sono lì, sono a teatro, non sono in carcere. Lì si evitano le discussioni perché ti senti tranquillo, libero, disteso. Vivi una connessione con gli altri completamente diversa».
Immagino che con voi in compagnia ci siano anche stranieri che non parlano bene l’italiano. Riuscite a comunicare attraverso il movimento?
«Assolutamente sì. Quando si dice “stare in ascolto” lo si fa anche se ci si guarda negli occhi senza dire una parola. Per dire a qualcuno che gli voglio bene e che gli sono vicino, l’abbraccio e quell’abbraccio lì lo si sente. Si figuri cosa vuole dire condividere una cosa così forte in piena libertà di movimento, su una base musicale emotiva, all’interno di uno spazio in cui vige la sospensione del giudizio e dei convenevoli formali che esistono ovunque. Quello che si pensa è che facendo teatro ed essendo un attore si finga, si sia falsi. L’attore, invece, è proprio quello che non è falso perché in teatro è sempre buona la prima. Io in quel teatro non ho mai avuto bisogno di essere falso: fingo di essere in un posto che non è quello, fingo una situazione che non è la mia per illustrarla, ma questa non è falsità. Sono vero nella mia finzione».
Le è mai capitato di fingersi qualcun altro dentro o fuori dal carcere?
«Francamente no. Non mi sono mai vergognato e non mi sono mai sentito falso nella mia vita quotidiana fuori dal carcere. Sono una persona abbastanza diretta e schietta e la falsità non è una mia attitudine. È ovvio che ogni tanto mi freno per quieto vivere o per educazione. Sono ateo, ma se c’è un prete non bestemmio per rispetto. A teatro può succedere. In quel teatro si è autentici. Lì spariscono tutte le sovrastrutture. Nel momento in cui noi detenuti riusciamo a capire che ci siamo giocati la vita con un lancio di dati grazie ad un arricchimento culturalmente, allora riusciamo anche a comprendere perché abbiamo sbagliato. Vede, io dico sempre che i reati non hanno il prezzo esposto. Non possiamo fare i moralizzatori di nessuno perché non è il caso. Però grazie al teatro in carcere si riescono a capire tante cose di noi e della nostra vita. Il teatro è uno strumento che ciascuno può usare come meglio crede».
PATRIZIA PERTUSO
© RIPRODUZIONE RISERVATA