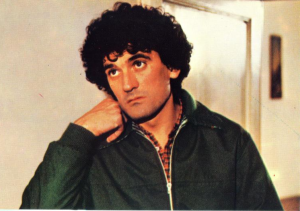Catrinel Marlon: «I manicomi oggi sono tra le mura domestiche»

Dal mondo della moda passa a quello del cinema, prima come attrice e ora come regista di “Girasoli”, al cinema dal 23 maggio, interpretato da una incredibile Gaia Girace. Lei è Catrinel Marlon.
Partiamo dal titolo. Chi sono i girasoli?
«I “girasoli” negli anni Sessanta erano i malati psichiatrici non aggressivi che avevano la possibilità di lavorare all’interno della struttura manicomiale, un po’ come i carcerati. Ho scelto questo titolo per il film perché lo intendo come un un inno all’amore, una via d’uscita dai momenti più bui, una guarigione attraverso la connessione tra esseri umani».
Dove è stato girato il film?
«Nel film c’è un luogo non-luogo anche se abbiamo scelto un cast napoletano importante. Volevamo girare ad Aversa, ma è stato impossibile perché in quella struttura c’erano troppi lavori murari da fare. Così abbiamo girato a Roma, d’inverno, nel mese di dicembre, nel sotterraneo dell’ex ospedale Forlanini».
La scelta del nome del manicomio che si vede nel film, “Santa Teresa di Lisieux”, si riferisce a qualcosa?
«E’ stata una scelta che abbiamo fatto con le altre due sceneggiatrici dopo una ricerca su Internet. Abbiamo scoperto che Santa Teresa da alcuni viene considerata come la Santa dei matti. Fra l’altro il primo ottobre si festeggia la sua festa liturgica e io sono nata il primo ottobre. Doveva per forza essere intitolato a lei».
Lei ha affrontato un tema più che delicato, quello della follia nei bambini. So che nella sua vita c’è stata una persona particolarmente importante affetta da una patologia mentale.
«Sì. Mi sono ispirata alla storia di mia zia Anca e al legame che c’era fra noi. Tutto ciò mi ha permesso di aggiungere una profondità emozionale nella regia che ho trasformato poi nell’intimità della storia tra Lucia ed Anna (Gaia Girace interpreta una ragazzina internata, e Mariarosaria Mingione vesti i panni di un’infermiera, ndr.)».
Lei ha iniziato il suo percorso di vita in una sorta di orfanotrofio in Romania, dove è nata. Che rapporto aveva con sua zia?
«La sorella di mia madre per me è stata fondamentale. L’orfanotrofio dove sono stata era una specie di collegio per neonati. All’epoca Ceaucescu aveva costruito queste strutture per offrire la possibilità ai giovani genitori di lavorare, di studiare e, non essendo consentito l’aborto, di lasciarci i bambini. Così i giovani che avevano un figlio e nessun supporto familiare lasciavano i neonati in queste strutture dal lunedì al sabato: li prendevano soltanto la domenica, per un giorno. Io ho trascorso i primi due anni e mezzo della mia vita in un posto così. Dopodiché mio padre, che era un atleta importante in Romania, ha vinto un concorso nazionale per i 400 metri a ostacoli e Ceaucescu gli ha regalato un monolocale. Mio padre ha deciso di smettere di praticare l’atletica e di trovarsi un lavoro. Fu mia madre a venirmi a prendere all’orfanotrofio per portarmi in quella che sarebbe stata la nostra. Mia zia, essendo la sorella più piccola di mia mamma, è stata quella che ha passato più tempo con me. Mi ricordo che la prima volta che ho bevuto il caffè: me l’ha fatto assaggiare lei quando avevo 7 anni. Con lei facevo i compiti. Ma dopo la morte di suo papà, mio nonno, è arrivata la malattia. È stato l’inizio di una trasformazione terribile come se da quel dolore fosse nata la sua schizofrenia. E io l’ho vissuta con lei».
Quanti anni aveva quando sua zia ha cominciato a star male?
«Tra i 15 e i 16 anni. Avevo appena iniziato a lavorare nel settore della moda e mi ricordo benissimo quando mia madre mi diede la notizia: ero su un pullman dall’altra parte di dove abitavo io in Romania e ci stavano portando a fare una sfilata in una città molto importante dove era in corso una Fashion Week. Mi arrivò una telefonata di mia madre nella quale cercava di raccontarmi il senso della vita. Quando le chiesi cosa cercava di dirmi, mi rispose che mia zia era impazzita. Non sapeva come dirmelo perché conosceva bene il legame che c’era tra noi e aveva paura che questa notizia potesse avere qualche ripercussione su di me. Ricordo le ultime ore di quel viaggio in pullman: le trascorsi rannicchiata, dondolandomi sul sedile a piangere. Per me era la fine. Immaginavo il momento dell’arresto e quando l’avevano rinchiusa. Era un dolore fortissimo. Per me la zia era la persona più importante di chiunque altro, compresa mia mamma».
Perché parla di arresto?
«Perché da noi solo la polizia può far internare qualcuno in un manicomio, non i familiari o i medici».
Nel suo film ci sono alcuni passaggi importanti. C’è una riduzione del corpo a terreno di prova per nuovi farmaci; lei mostra corpi contesi tra due medici che rappresentano due approcci diversi alla malattia: da una parte l’uso di elettroshock e il ricorso a diverse forme di costrizione e contenimento. Dall’altra, quella che sarebbe diventata con la legge Basaglia la “nuova cura”. Il film sottolinea anche la spersonalizzazione delle persone: si parla di “bambini rotti”, si vedono abiti, scarpe, oggetti personali lasciati nei depositi da qualcuno che non li userà mai più. In un dialogo tra Lucia e la dottoressa D’Amico (Monica Guerritore), la prima trova la sua identità nell’affermazione: “siamo matti”. E quando la dottoressa le dice che non è importante sapere cosa si è, ma chi si è inizia un gioco al massacro tra identità annullate. Quanto è difficile portare sul grande schermo l’identità della follia semmai la follia avesse un’identità?
«Quello che ha appena detto era il messaggio che volevo arrivasse. La follia, l’identità, l’attenzione verso l’altro. Tutto quello che noi oggi non abbiamo. Quando abbiamo scritto il film mi sono ispirata a quello che era il manicomio In Romania. Voi non c’è l’avete più dal 1978. Ho letto la vostra storia e ho scoperto l’esistenza dei “fagotti”, luoghi dove si mettevano le cose dei malati che non sarebbero più usciti perché venivano rinchiusi a vita. Per me era una cosa nuova perché da noi i manicomi avevano altre regole: erano luoghi dove un malato entrava per farsi curare e, all’incirca dopo tre mesi, ne usciva. Da voi negli anni Sessanta – il periodo in cui io ho ambientato il film – non c’era ancora una definizione precisa di tante patologie psichiatriche: un bambino “strano” invece di essere portato all’orfanotrofio finiva al manicomio come ci finivano quelli nati dalle donne “non per bene”. Erano luoghi orribili dove si subiva di tutto compreso l’elettroshock sui genitali. Abbiamo scelto di non far vedere tante pratiche, ma solo di farle intuire per evitare che il film diventasse troppo duro. Ma questa era la vostra realtà. C’erano dei padiglioni pieni di bambini recuperabili ma irrecuperabili, i cosiddetti “bambini rotti”».
Lucia ad un certo punto dice: “Qui dentro, se cresci, sei morto”. La condizione di bambino è sicuramente devastante per quello che ha appena detto ma, paradossalmente, offre una collocazione sociale precisa: finché si è bambini si è al riparo da una serie di cose che invece succedono ai più grandi, nel Padiglione 17 dove “c’è l’orrore”.
«Esattamente. Secondo una regola dei manicomi di quegli anni i bambini tra i zero e i 16 anni non compiuti, maschi e femmine, stavano insieme. Una volta compiuti i 16 anni venivano spostati nei padiglioni degli adulti e lì era tutto più difficile perché si sapeva che non ci sarebbe stata più una via d’uscita. Per questo i bambini sperano di diventare “girasoli”. Lucia, in particolare, non vuole tornare a casa dalla sua famiglia, dalla madre che odia. Vuole essere libera, pur restando all’interno di una struttura manicomiale come se quel posto fosse l’unico che le permetta di vivere».
Le ha vissuto la pazzia sulla sua pelle e poi l’ha fatta rivivere in questo film. Qual è il modo migliore, non per affrontare, ma per gestire la follia?
«Offrire ascolto. È una cosa che noi oggi non facciamo più, non diamo ascolto a chi ci sta accanto. In Italia un mancato supporto sanitario adeguato ne è la prova. I veri manicomi, oggi, sono tra le mura domestiche, tra i familiari. E questo porta ad un maggior grado di esclusione. Paradossalmente, un malato, essendo rinchiuso in un manicomio, ha la percezione di essere sottoposto a una cura. Oggi, invece, sia chi ha una patologia sia i suoi familiari vengono lasciati soli. Soprattutto i genitori di bambini malati psichiatrici non hanno alcun aiuto».
Due curiosità. È un caso che i personaggi chiave del suo film siano donne?
«No, non lo è. Ho voluto fare un film al femminile. Ho iniziato a scrivere la sceneggiatura con una mia amica durante una vacanza in barca. Poi abbiamo sentito la necessità di avere un rinforzo. Ma doveva essere una donna perché le donne hanno più emozioni, più sentimenti, sono più delicate. Tutte e tre, poi, abbiamo optato per un cast al femminile. Forse perché le donne hanno una marcia in più….».
Questa contrapposizione tra maschile e femminile è resa anche nella scelta dei due personaggi che interpretano i medici e hanno visioni opposte della cura?
«Assolutamente sì. Non è un caso che nel film, quando due dottori maschi si incontrano e parlano fra loro, si dicano convinti che “la follia è femmina…”».
PATRIZIA PERTUSO
© RIPRODUZIONE RISERVATA